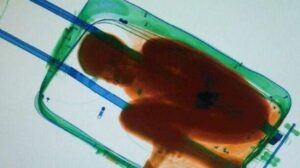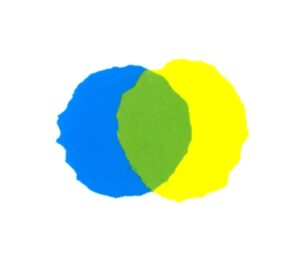Aleggia l’odore del bagnato, in questo lurido pub di legno di Primavalle.
Come ci sono capitato, non lo so nemmeno io.
– Una Wellington Scotch Ale…
– Che roba è? – mi risponde il cameriere, un tizio hiphoppettaro, sui trentacinque, che di tutto trasuda, tranne che di esperto sommelier.
– Dammi una birra scura, che non sia amara.
La desolazione di una vita attraverso una birretta di periferia. Tra i cocci del passato e la noia del presente. Lontano da casa mia, dalla mia famiglia, a vendere sim telefoniche per la Cipt.
Elegante come un traditore, mi allento la cravatta e nascondo sotto le gambe la ventiquattrore. Tutto il mio lavoro è lì dentro.
– Scusi, ma lei è Maurice Delemberte?
Una voce leggera, timida. Pura come i miei scritti giovanili.
Mi volto, stranito e indemoniato, e la voce continua, senza aspettare risposta: – Sono il tuo specchio!
“Sono il tuo specchio”, quello che rispondeva Dio ad Antonine nel mio “Piccioni e farfalle fanno la rivoluzione”.
– Non conto un cazzo, senza di te, mio autore.
Un fulmine a ciel sereno, sotto le vesti di uno studentello universitario. Mi si sta manifestando un ente superiore?
– Tu sei Dio? – azzardo a chiedergli, inebriato dalle emozioni più che dalla scura che ho appena sorseggiato.
– No, Signor Delemberte. Sono un suo lettore e conosco perfettamente ogni suo libro.
– Li hai trovati su una bancarella?
-No, su eMule… – risponde prontamente, ma subito abbassa lo sguardo, ripensandoci imbarazzato. – Mi scusi. Non avrei dovuto dirglielo. E’ che avevo bisogno di leggerla, ma non ho tanti soldi.
– Hai fatto bene, continua così, spenditi tutto in libri seri e non in cazzate come le mie.
– Ma i suoi sono capolavori!
– Capolavori un cazzo, guarda che fine ho fatto. Dimenticato e umiliato da gran parte del genere umano. Costretto a fregare la gente per portare pane a casa. Nascondendo i miei sogni a mio figlio per non soffrire insieme a lui, un giorno. Quando anche i suoi sogni si infrangeranno addosso a qualche fredda Istituzione.
Il ragazzo mi vede, mangiandomi con gli occhi, e sembra non ascoltarmi. Resta immobile, come se stesse godendo del nostro incontro, al punto da voler evitare qualsiasi granello d’aria che possa muoversi contro la sua idea dell’esserci, in due, lì, assieme. Finalmente.
– Ma ora lei è qui, Signor Delemberte, Dovrà candidarsi a sindaco del paese. Lo prenda come un dovere.
– Ragazzo, cosa ti sei iniettato nelle vene, acido muriatico? Ti stai sciogliendo dietro alla scia delle merdate che avevi sparato all’inizio. Ed io, che ti avevo preso sul serio…
– Dico veramente, abbiamo bisogno di uno come lei. Abbiamo bisogno di uno sceriffo, di un sognatore che sappia poetare la nostra rivoluzione.
– Ma stai scherzando… Io sindaco? Sceriffo di questo posto sperduto?
– Cosa ha da perdere?
Ordino un’altra birra, butto giù qualche chilogrammo di aria pesante, chiudo gli occhi e in pochi minuti intorno al mio tavolo vedo formarsi un capannello di personaggi, lenti e oziosi nei corpi, ma con uno strano fulgore negli occhi, come una speranza latente emersa improvvisamente da un lungo torpore. Rompe il silenzio il primo.
– Io mi drogo di macchinette, getto spicci in una slot machine, ma non sono ancora schiattato, -inizia il primo. – Qui non c’è nessuno. Non la conosco, ma la prego: ci aiuti.
Gli fanno eco gli altri sei:
– Questo è un quartiere popolare, fatto di guerre tra poveri. Non chiediamo niente, vogliamo solo che i nostri bambini riprendano a giocare a pallone per le strade. Vogliamo gridare insieme. Piangere addosso a qualcuno e non chiusi al cesso, tra una sigaretta e l’altra. Siamo comunisti rimbecilliti. Siamo disoccupati. Gente che combatte contro lo sfratto e chiede lo sconto sulla verdura al mercato della domenica. Lei ha studiato…
Penso agli anni dell’università, anni buttati. Penso che ora dovrei tirare fuori i contratti e piazzare qualche abbonamento telefonico, per concludere la giornata. Ma non ce la faccio. Li guardo in faccia, uno per uno. Afferro il bicchiere per restare indifferente.
– Presentatevi, – dico bruscamente.
– Sono Piero, un meccanico senza officina, campo di pezzi rimediati. Riparo le macchine sul posto, con gli strumenti di una volta. Le chiavi.
– So’ Gino, un muratore di cinquantacinque anni. Mi ha rovinato la trippa, guarda qua. Ho preso peso mentre facevo esperienza. Dai calcinacci alla posa delle mattonelle, poi la crisi. Le ditte chiudevano e io invecchiavo. Ora vivo alla giornata. Se qualcuno mi chiama…
– Luchino, infermiere. Anzi, ex-infermiere. Mi hanno segato.
– Io sono Birillo, ho abbandonato la scuola e non so che fare.
– Amadou, sono uno straniero, vengo dal Mali.
– Io sono Nino Ceccaretti, un pensionato che si piscia sotto, Ho problemi alla prostata, ma non si preoccupi. Sono uno tosto!
Il giocatore d’azzardo si chiama Totonno e poi c’è il lettore di “Piccioni e farfalle…”, Noè.
– Delemberte, si ricorda cosa dicevano i piccioni ad Antonine?
Noè si gira verso il bancone e fa un fischio per richiamare l’attenzione del cameriere hiphoppettaro: – Dammi le chiavi del bagno.
Il cameriere gliele lancia, Noè le afferra al volo e mi fa un cenno con la testa: – Si alzi e mi segua.
– Voi siete fuori di testa, ma che diamine sta succedendo?
Dal buio vedo spuntare fuori uno zingaro che si affretta a tirare giù la serranda per bloccare l’uscita.
Inizio a tremare. Vaffanculo, dovevo tirare fuori i contratti. Maledico il mio orgoglio. Dannata scrittura.
Noè fulmina lo zingaro: – Ma cosa fai? Non devo spacciare, dobbiamo andare al bagno per un’altra questione.
Mi tranquillizzo per un momento, mentre la serranda si riapre, ma cerco di mettere le cose in chiaro: – Ragazzino, io non devo pisciare e finora non l’ho mai tenuto a nessuno.
– Per piacere, mi segua.
Amadou mi tende la mano. Cazzo, è alto quasi due metri. Ha lo sguardo innocuo, però. Un po’ per timore (oramai non mi fido più di nessuno), un po’ per disperazione (non ce la faccio più a rompermi le palle in giro), decido di assecondare questo siparietto.
– Andiamo.
Amadou e gli altri sei mi stanno dietro, Noè mi fa strada.
Sulla porta del bagno è attaccato un cartello con il disegno di una scimmia che si cala le mutande e la scritta “Centrate il bersaglio, qui il bagno non si pulisce da solo”.
Una volta dentro quei quattro metri quadrati, gli occhi sono tutti per le centinaia di scritte sui muri. Di colori diversi. Di grafie diverse. “Irina Troia”, “Forza Roma”, “Tutti i servi dei padroni c’hanno rotto li cojoni”. Tra bestemmie e inni alla fica, il mio sguardo si inchioda su angolo di muro. E leggo:
“Il piccione guardando Antonine gli disse: – Eravamo morti di fame perché ci avevano tolto il pane. Abbiamo iniziato a beccare qua e là, ad arrangiarci con lo spazzatura. Eravamo considerati bestie e non più angeli, perché neri. Abbiamo continuato a volare. Ci volevano mettere in gabbia, siamo rimasti in città. Abbiamo occhi ingialliti dalle lacrime e zampe rosse che raccolgono il nostro sangue. Pieni di cicatrici, coperti di piume e di tanta polvere. Caghiamo addosso ai passanti per essere guardati. Siamo maledetti. Siamo tanti. Antonine, mettici insieme. Dacci entusiasmo, rendici reali.
Antonine prese il megafono ed iniziò a cantare la loro rivoluzione.”
PAGE 9