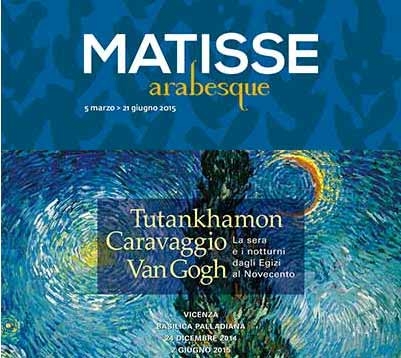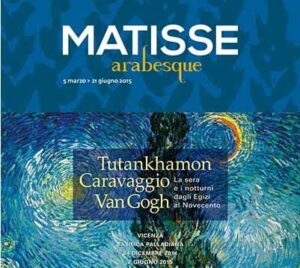ROMA – Un foglio, una tela, un blocco di marmo o uno spartito sono solo spazi, cornici in cui operare, universi vuoti dalle infinite possibilità. Il tempo o la materia vincolano l’azione creativa: ciò che di implacabile accade nella vita non può non manifestarsi anche nell’arte. Per far emergere l’idea, per impressionare, l’artista compone gli elementi in suo possesso, segni, colori, parole, dando loro una forma.
I materiali sono infiniti – la storia dell’arte del XX secolo lo ha dimostrato – ed è il modo di plasmarli, di accostarli, di fonderli, di scinderli la sola questione decisiva, quella che più conta, ciò che permette un contatto sincero tra l’opera e il pubblico.
Ogni mostra è un atto creativo, un’idea che mette in moto il gusto e le conoscenze di uomini, che entro un tempo determinato, data una cornice spaziale ben definita, decidono di manifestare il proprio pensiero, trattando il materiale sublime che è l’opera d’arte.
L’idea tiene uniti gli elementi e guida il pubblico lungo un sentiero fatto di intuizioni; lo spirito critico del visitatore è scosso, sollecitato, e la creatività, per contagio, può riprodursi all’infinito.
Ciò che rende grande una mostra, quindi, non è il numero delle opere, la loro provenienza, la loro antichità, ma il tessuto intellettuale che le tiene unite e le fa dialogare tra loro e con il pubblico; un capolavoro letterario può essere anche privo di termini aulici o architetture sintattiche raffinatissime: l’arte di Kafka ne è un esempio. La profondità dell’idea ed il modo di trattarla costituiscono la vera essenza di ogni azione creativa.
“Matisse. Arabesque”, alle Scuderie del Quirinale, è la dimostrazione che la solidità concettuale va ben al di là del desiderio infantile di stupire, di creare atmosfere destinate fatalmente a dissolversi pochi minuti dopo aver varcato la porta di uscita del museo: è una mostra intima ed intrigante, perché penetra la periferia più buia di un artista, la genesi della creazione, la sua ispirazione.
Tappeti, tende, abiti e cinture femminili giapponesi, ceramiche siriane, turche, irachene e coreane illuminano il visitatore, senza stordirlo, lungo quel sentiero che portò un giorno Henri Matisse a dire nel 1924: “Presto mi venne come una rivelazione, l’amore della materia per se stessa, sentì svilupparsi in me la passione del colore. In quel momento si apriva la grande Esposizione di arte maomettana. Con quale piacere scoprì le stampe giapponesi, che lezione di purezza, di armonia ne ricevetti. Solo con lentezza giunsi a scoprire il segreto della mia arte. Consiste nel meditare a contatto con la natura, per esprime un sogno sempre ispirato alla realtà”.
Gli oggetti in mostra, accostati ai dipinti e agli studi su carta del maestro francese, non si riducono ad una finestra, più o meno suggestiva, da cui il pubblico passivamente osserva la luce del decorativismo orientale riflessa sul gesto di Matisse, ma impongono una valutazione attenta della crisi che l’artista conobbe quando decise di lasciarsi alle spalle la tradizione occidentale e l’esperienza dell’avanguardia, per smarrirsi nel labirinto delle civiltà antiche.
Inutile elencarne i capolavori: bisogna andare alle Scuderie del Quirinale e comprendere la storia di un uomo che mette in discussione tutto ciò che ha realizzato, per continuare a vivere, senza paura, la febbrile emozione della sfida.
“Matisse. Arabesque”, non può non interrogare il pubblico e gli addetti ai lavori sul primo dovere di un percorso espositivo, sul modo di fare arte con l’arte, senza mentire, senza dover per forza accecare le persone per suscitare in loro stupore; impressionare vuol dire turbare, provocare una forte sensazione e lasciare un segno, un’impronta.
Per comprendere fino in fondo l’armonia di una mostra come questa, bisognerebbe visitarne un’altra, a Vicenza, ben più grande, accolta con frasi come“E’ un’idea così semplicemente bella che stupisce che nessuno ci abbia pensato sino ad ora”: questo è ciò che silegge sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
La mostra in argomento gode di una cornice unica al mondo, la Basilica Palladiana; il titolo è sbalorditivo: “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento”. Diamo i numeri: 115 le opere esposte, sei le sezioni, 22 i reperti dell’antico Egitto provenienti dal prestigioso museo archeologico di Boston.
All’appello di Marco Goldin, il curatore dell’evento, rispondono i nomi più fragorosi della storia dell’arte: Mondrian, Rothko, Monet, Turner, Bacon, Cezanne, Gauguin, Rembrant e tanti altri. Tanti veramente: Giorgione, Tiziano, El Greco, Piranesi. Sfilano anche le tele di Friedrich, Corot, Hopper, Mondrian, Klee, Pissarro. Impossibile ricordarli tutti, addirittura inutile.
Di indimenticabile ed irritante, quanto l’ingordigia di un bambino, che non sapendo bene quale dolce scegliere, supplica sua madre di acquistare tutto ciò che è esposto sul bancone, è il filo conduttore dell’allestimento.
Entriamo in punta di piedi nella “sera e i notturni” di Marco Goldin e sfogliamo le pagine della sua curiosa creazione. Si parte con il tema della “notte eterna e spirituale”: quando ce di mezzo il mistero, la cultura egizia è un evergreen. Goldin sa bene che dal mistero a Gesù Cristo il passo è breve e chiama a raccolta i maestri di arte sacra del Cinquecento e del Seicento. Poi il paesaggio, con cui non si sbaglia mai. Qui si va dal Romanticismo al pieno Novecento. L’ultima sezione, la sesta, è un sunto di tutto quello che è esposto lungo il percorso.
“Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento” è un evento ipertrofico, che qui in Italia, va detto, è in grado di organizzare solo una società come Linea d’ombra.
Le capacità produttive della macchina di Marco Goldin, però, non riescono a mascherare lo squilibrio di chi sembra aver dimenticato una lezione a dir poco primordiale: una qualunque immagine, un’idea, un suono, se eccessivamente amplificati diventano illeggibili, impossibili da percepire, oscuri e assordanti. Possono addirittura confondere ed essere nocivi. Possono ingannare.
Arredare uno spazio ed allestire una mostra sono attività che non andrebbero mai confuse. Semplicità e misura, anche in casi come questi, sono sinonimi di gusto e sincerità.